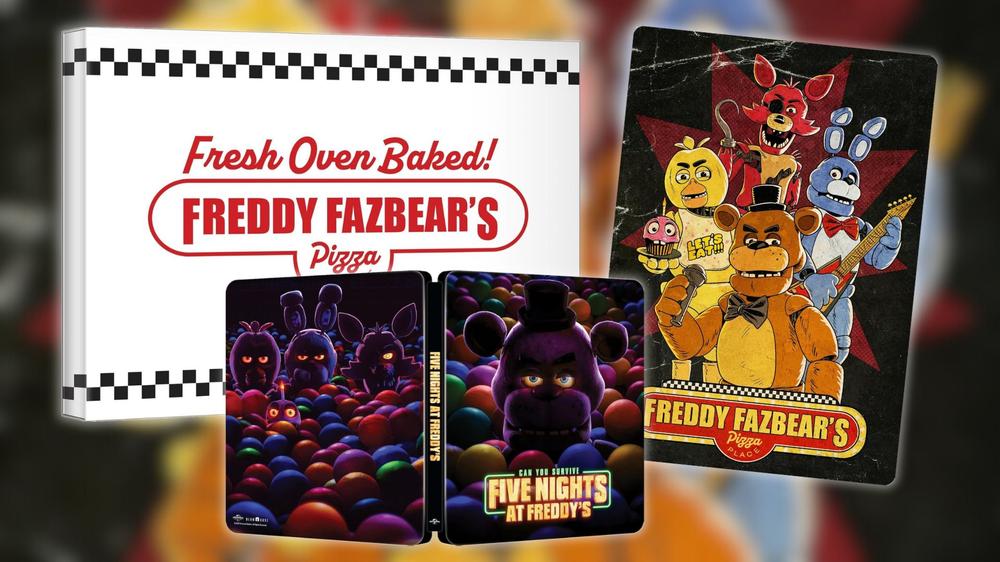C’è un materiale che potrebbe rivoluzionare il modo in cui ricarichiamo tutto: smartphone, auto elettriche, droni e perfino le reti elettriche. È il grafene, o meglio, una sua nuova versione messa a punto all’Università di Monash, in Australia.
Il problema, fino a oggi, era semplice: le batterie immagazzinano molta energia ma si caricano lentamente, i supercondensatori si caricano velocemente ma hanno poca energia. Questo nuovo materiale sembra aver trovato il punto di equilibrio perfetto.
Si chiama multiscale reduced graphene oxide (M-rGO) ed è ottenuto dalla grafite naturale, molto comune in Australia. I ricercatori hanno scoperto che, modificando il modo in cui viene “cotto” con un trattamento termico velocissimo, il grafene assume una forma super ricurva con canali ordinati in cui gli ioni scorrono come in un’autostrada. Risultato? Quasi tutta la superficie del materiale diventa utilizzabile per immagazzinare carica.
Numeri alla mano, parliamo di densità energetiche che raggiungono i 99,5 Wh per litro, paragonabili a quelle delle batterie al piombo, ma con una potenza di picco di 69,2 kW per litro. Tradotto: tanta energia e la possibilità di scaricarla (o ricaricarla) in tempi lampo. E non è tutto: i test mostrano che la durata nel tempo è ottima, con cicli di carica e scarica che non ne compromettono la stabilità.
“Questa scoperta ci permette di pensare a supercondensatori che, in alcuni casi, potrebbero sostituire del tutto le batterie”, spiega il professor Mainak Majumder, a capo del progetto. E la notizia interessante è che non si tratta solo di laboratorio: il materiale è già in produzione grazie alla startup Ionic Industries, spin-off della stessa università, che lo sta realizzando in quantità commerciali.
Immaginate le applicazioni: auto elettriche che si ricaricano in pochi minuti, droni con più autonomia, dispositivi elettronici che non ti lasciano a piedi. Ma anche stabilizzare le reti elettriche, accumulando energia rinnovabile e rilasciandola nei momenti di picco.
Lo studio, sostenuto anche dall’Australian Research Council e dall’US Air Force, è stato pubblicato su Nature Communications.

 Early October Prime Day Deal Brings Huge Wins for Batman Fans – These Comics Are Included in Kindle Unlimited
Early October Prime Day Deal Brings Huge Wins for Batman Fans – These Comics Are Included in Kindle Unlimited