Un piccolo cranio antichissimo è riuscito a raccontare molto più di quanto ci si aspetti, rivelando informazioni preziose sull'evoluzione dell'uomo. È quanto emerge dall’analisi di un fossile ritrovato quasi un secolo fa nella grotta di Skhul, in Israele, e oggi al centro di un nuovo studio internazionale. Si tratta dello scheletro di un bambino di circa cinque anni, vissuto 140.000 anni fa, che porta con sé un dettaglio sorprendente: mostra tratti sia dei Neanderthal sia dei primi Homo sapiens.
La ricerca, guidata da Israel Hershkovitz dell’Università di Tel Aviv e da Anne Dambricourt-Malassé del CNRS francese, ha utilizzato tecniche avanzate di micro-TC per ricostruire in tre dimensioni la morfologia cranica e mandibolare. L’osservazione ha rivelato un curioso mosaico: la calotta cranica si piega in modo simile a quella di Homo sapiens, mentre la mandibola, l’orecchio interno e il sistema di vasi sanguigni intracranici ricordano i Neanderthal.
Secondo gli autori, questo bambino rappresenta la più antica prova fisica di incrocio tra le due popolazioni umane, molto prima di quanto ipotizzato finora. Se gli studi genetici moderni indicano che circa il 2-6% del nostro DNA proviene dai Neanderthal a seguito di contatti avvenuti tra 60.000 e 40.000 anni fa, il fossile di Skhul sposta la lancetta indietro di quasi 100.000 anni.
Per decenni si era creduto che i Neanderthal si fossero evoluti in Europa e fossero giunti nel Levante solo 70.000 anni fa. Le scoperte più recenti hanno invece ribaltato questa visione: resti provenienti dal sito di Nesher Ramla, datati a 400.000 anni fa, suggeriscono la presenza di gruppi pre-neandertaliani nella regione ben prima dell’arrivo dei sapiens dall’Africa. È in questo contesto che il bambino di Skhul diventa un tassello fondamentale, confermando che l’incontro fra i due gruppi era avvenuto già 200.000 anni fa e che il Mediterraneo orientale fu davvero un crocevia dell’evoluzione umana.
Il confronto con altri ritrovamenti, come il cosiddetto “bambino di Lapedo” rinvenuto in Portogallo nel 1998, che mostrava anch’egli un mix di caratteristiche ma datato a soli 28.000 anni fa, rende ancora più evidente la portata della scoperta. Il caso di Skhul non si limita a un’anomalia isolata, ma testimonia un processo di interazione continua tra comunità diverse che hanno condiviso territori, strumenti e geni.
L’analisi delle strutture non visibili a occhio nudo, come l’orecchio interno e il sistema vascolare, ha permesso di superare vecchie classificazioni. Per lungo tempo, infatti, i fossili di Skhul e della vicina Qafzeh erano stati etichettati come “primi Homo sapiens”. Oggi si comprende che almeno alcuni di essi appartenevano a individui con un patrimonio genetico misto, frutto di incroci che hanno lasciato tracce fino al nostro tempo.
La scoperta, pubblicata sulla rivista l’Anthropologie, mette in luce quanto fosse dinamica e intrecciata la storia umana in Medio Oriente, dove antiche popolazioni non vivevano isolate ma si influenzavano a vicenda, dando vita a nuove combinazioni fisiche e genetiche.
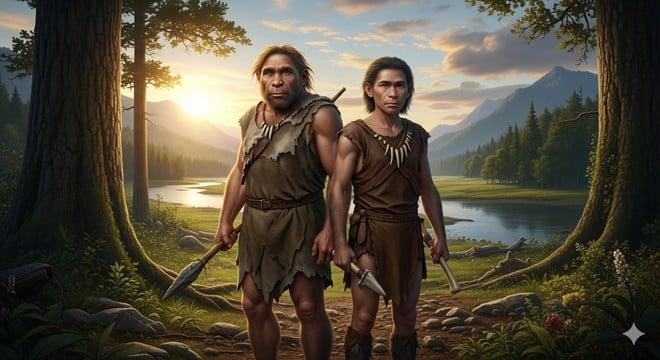
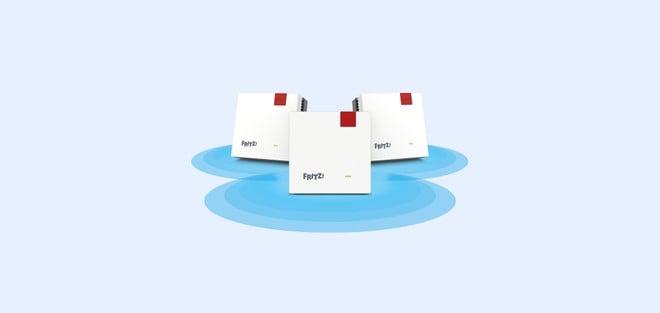 FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 ufficiale: rete stabile ovunque fino a 3.000 Mbps
FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 1600 ufficiale: rete stabile ovunque fino a 3.000 Mbps