Nel 2023, un annuncio aveva acceso l’immaginazione collettiva: il telescopio spaziale James Webb (JWST) avrebbe rilevato nell’atmosfera dell’esopianeta K2-18b segnali compatibili con la presenza di vita, tra cui una possibile firma del dimetilsolfuro (DMS), una molecola prodotta sulla Terra solo da organismi marini. Le dichiarazioni provenivano da un team di ricercatori dell’Università di Cambridge e avevano indicato questo mondo lontano 124 anni luce come un potenziale "Hycean world", con oceani liquidi sotto un’atmosfera densa e idrogenata.
Ma l’entusiasmo è stato presto seguito da un’ondata di scetticismo. Una nuova analisi condotta da un gruppo internazionale di ricercatori, tra cui Rafael Luque (Università di Chicago), Caroline Piaulet-Ghorayeb e Michael Zhang, ha rianalizzato i dati e sostiene che le prove a favore del DMS siano troppo deboli per essere considerate significative. “Non abbiamo mai osservato più che accenni insignificanti di DMS o del suo analogo DMDS,” spiegano i ricercatori, i cui risultati sono stati pubblicati in un preprint su arXiv.
La nuova analisi ha confrontato in modo congiunto i dati di tre strumenti fondamentali del JWST: NIRISS, NIRSpec e MIRI, coprendo l’intero spettro dall’infrarosso vicino al medio. Secondo Zhang, i risultati iniziali presentavano discrepanze interne: i dati MIRI suggerivano temperature molto più alte rispetto a quelli ottenuti dagli altri strumenti. Analizzare tutto con un modello unico ha permesso agli scienziati di costruire una lettura più coerente e affidabile dell’atmosfera del pianeta.
L’errore principale, secondo Piaulet-Ghorayeb, è stato affidarsi a un dataset iniziale limitato e poi generalizzarne i risultati. “Quando abbiamo integrato le osservazioni più recenti con quelle già raccolte due anni prima, il segnale forte segnalato nel 2025 si è ridotto notevolmente,” afferma. Inoltre, alcune delle firme spettrali attribuite al DMS possono essere replicate anche da molecole abiotiche comuni, come l’etano, il cui spettro differisce per un solo atomo.
La difficoltà principale risiede proprio nella risoluzione spettrale: distinguere due molecole quasi identiche con gli strumenti attuali è un’impresa ardua, specialmente a distanze interstellari. “Fino a quando non saremo in grado di separare in modo netto questi segnali, dobbiamo essere molto cauti nell’interpretarli come prove di vita,” aggiunge Piaulet-Ghorayeb.
Anche la valutazione statistica del segnale è stata criticata. La rilevazione iniziale era definita “tentativa”, ma il paper successivo parlava di una significatività a 3 sigma — un valore ancora lontano dalla soglia di 5 sigma richiesta per dichiarare una scoperta. “Sorprende che sia stato sufficiente per rinforzare pubblicamente l’ipotesi del DMS come biomarcatore,” commenta Luque.
I ricercatori non mettono in dubbio le potenzialità del JWST, ma mettono in guardia contro interpretazioni affrettate: “È un telescopio incredibilmente potente, ma i segnali che stiamo cercando sono piccolissimi,” sottolinea Piaulet-Ghorayeb. L’invito, quindi, è alla prudenza sia da parte della comunità scientifica sia da parte dei media: “Le rivendicazioni straordinarie richiedono prove straordinarie,” conclude Luque, citando Carl Sagan.
JWST continuerà a osservare K2-18b nei prossimi mesi, ma non si prevede che le prossime rilevazioni siano in grado di confermare direttamente la presenza di vita. Ci si aspetta invece di comprendere meglio la composizione atmosferica e le caratteristiche interne del pianeta, mantenendo accesa la speranza — ma con i piedi ben saldi per terra.
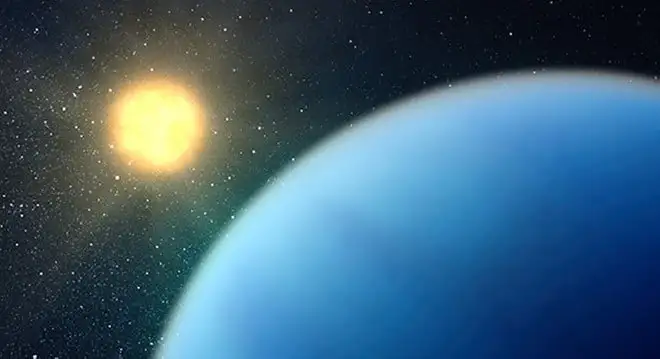
 La Commissione Europea attacca Shein: basta sconti finti e etichette ingannevoli
La Commissione Europea attacca Shein: basta sconti finti e etichette ingannevoli