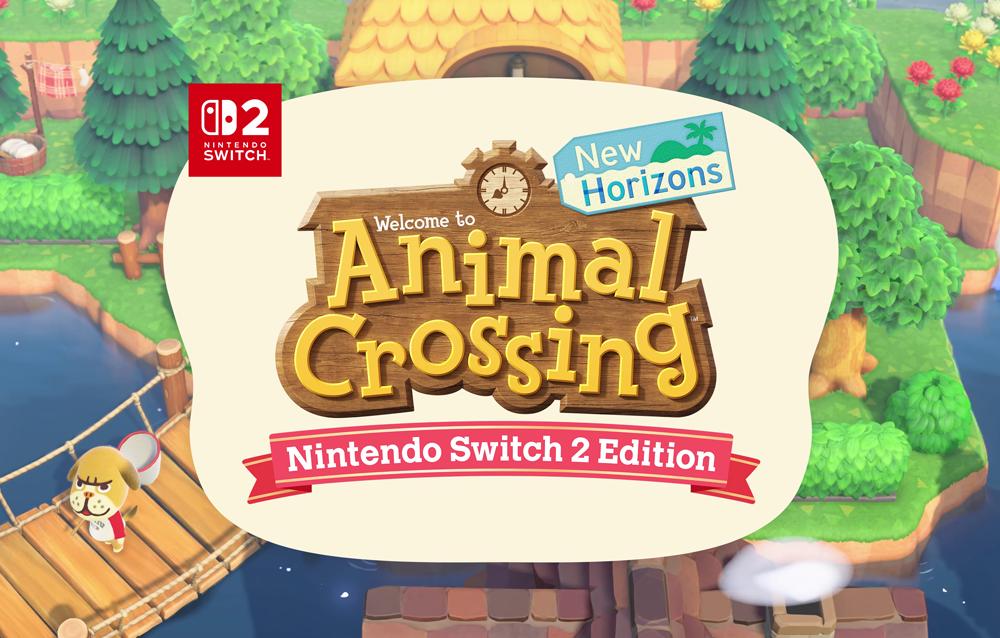Con una mossa culturalmente rivoluzionaria, il parlamento francese ha approvato il 30 ottobre 2025 un emendamento secondo cui il reato di stupro non è più definito solo in base a "violenza, coercizione, minaccia o sorpresa", ma anche sulla base della mancanza di consenso. In particolare il nuovo testo recita che "qualsiasi atto sessuale non consensuale commesso su un’altra persona … costituisce aggressione sessuale / stupro". In Italia non si parla esplicitamente di "consenso" (e le parole fanno la cultura) ma nei fatti è ben considerato. Andiamo con ordine.
Gisèle Pélicot dopo la sentenza parla alle vittime di violenza: "Condividiamo la stessa lotta"le parole modellano il pensiero e il pensiero è cultura
In Francia e negli altri Paesi i cui codici penali nominano questo concetto, il consenso viene definito come libero, informato, specifico, previo e revocabile. Come nei fatti viene considerato in Italia anche quando non è esplicitamente scritto sul codice. Significa che il silenzio o la mancanza di reazione della vittima non possono essere interpretati come consenso. Rimane, ovviamente, da intendersi come stupro quando l’atto è commesso con violenza, coercizione, minaccia o sorpresa.
Le parole sono importanti: questo emendamento stabilisce formalmente nella legge ciò che molti/e attivisti/e richiedevano, anche per l'effetto educativo di una legge che parla con il giusto linguaggio e aiuta a modellare una cultura del consenso. Adesso, con il consenso al centro, il principio teorico è: se non c’è consenso, c’è reato, anche senza violenza. Tecnicamente in tribunale cambierà poco: il/la giudice continuerà a valutare indizi, testimonianze e circostanze, non è che sa leggere nel pensiero. Tanto che anche lo stesso legislatore francese ha sottolineato che l’introduzione della nozione di consenso non garantisce automaticamente più condanne: la pratica giudiziaria, prove, formazione degli operatori e operatrici della macchina della giustizia contano moltissimo. Il consenso infatti è uno stato mentale quindi non c’è un modo diretto per misurarlo. In tribunale si continua a usare gli stessi strumenti probatori di prima, solo con un nuovo filtro concettuale: testimonianze, circostanze dell’atto, comportamento dell’aggressore, prove fisiche o digitali (messaggi, chat, foto, droghe, alcol).
Il cambiamento culturale è evidentemente enorme: la legge dichiara apertamente che solo un “sì” libero e consapevole è valido. Questo cambia il dibattito pubblico, l’educazione, la percezione dei rapporti sessuali. Da una prospettiva penale/pratica invece il cambiamento è minimo. I processi restano basati su prove, testimoni, circostanze: dimostrare che il consenso non c’era resta complesso, così come è complesso dimostrare che c'era.
Il codice italiano resta su un linguaggio oggettivo e misurabile
Nel caso francese, la legge considera assenza di consenso anche se c’è silenzio o passività: quindi il fatto che la vittima non abbia detto “sì” esplicitamente può essere rilevante (e problematico, vista la sfera a cui attiene cioè l'erotismo). In Italia la situazione è leggermente più complicata perché il diritto penale resta ancorato al paradigma della violenza/coercizione.
La legge italiana non ha ancora adottato una definizione di stupro basata sul consenso come principio autonomo: il reato di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) richiede che ci sia violenza, minaccia o abuso di autorità. Questo modello considera il reato come un atto imposto dall’aggressore, quindi il focus è sulla condotta dell’aggressore più che sulla volontà della vittima. E poi nella pratica la parola “consenso” non serve: implicitamente, se c’è violenza o minaccia, si assume che la vittima non abbia accettato l’atto.
Siamo consapevoli del portato culturale del linguaggio, ma va detto che anche senza usare la parola "consenso", la legge richiede alla vittima di manifestare rifiuto o dimostrare resistenza, in pratica c'è il concetto di “dissenso” tanto è vero che giudici e avvocati/e parlano spesso di assenza di consenso quando anche la legge non lo nomina e anche in assenza di prove di coercizione. Perché non si è ancora cambiato è presto detto: la paura di introdurre un concetto talmente soggettivo e talmente legato alla sfera istintuale, intima e psicologica che è difficile da misurare o identificare oggettivamente.
facile dire di "solo sì è sì": difficile è interrogare le vittime per ore
E poi c'è una cultura legale che considera l’atto sessuale come reato solo se imposto con forza o minaccia e l’idea del "consenso mancante" è implicita, rimanendo fuori dal linguaggio come elemento autonomo (è pure relativamente nuova in Europa). Introdurre il consenso come elemento centrale creerebbe difficoltà concrete ai tribunali italiani: dovrebbero accertare uno stato mentale, valutare l’assenza di consenso e trovare strumenti probatori chiari o identificare per esempio il sesso consensuale ma non desiderato (i motivi psicologici per cui si concede il rapporto sessuale pur senza volerlo davvero e senza quindi opporsi, nemmeno mentalmente).
Restano le differenze "chiave" nella pratica, rispetto alla Francia (e agli altri Paesi che hanno messo il consenso al centro): in Italia, sulla carta almeno, la mancata reazione di una vittima o un suo silenzio (non dice di "no") non bastano per configurare il reato. Serve dimostrare violenza o minaccia: il reato si valuta focalizzandosi sul comportamento dell’aggressore più che sullo stato mentale della vittima. In Francia invece dal 30 ottobre 2025 il silenzio o la passività non verranno considerate consenso, e questo apre la porta a casi in cui prima non sarebbe stato possibile procedere.
Ora, le leggi italiane non dicono "solo sì significa sì" (ma la Cassazone sì) e quindi spesso nei casi di violenza sessuale i processi restano centrati su elementi oggettivi di coercizione. La riforma che mette consenso al centro è possibile, ma richiederebbe cambiamenti legislativi, giurisprudenziali e culturali profondi, non solo un cambio di parole.
i processi per stupro diventerebbero infinitamente lunghi
Il processo penale in Italia cambierebbe se si adottasse il consenso? Si e no. Oggi succede che quando una persona denuncia un abuso, si apre l’indagine e ci si concentra su prove di violenza o minaccia (ferite, testimonianze, video). La difesa dell'accusato può sostenere che non c’era coercizione, quindi niente reato, e infine il giudice decide sulla base di elementi di forza oggettivi (e della sua discrezionalità e preparazione). Inserendo il tema del consenso, dopo la denuncia l’indagine si concentrerebbe sull'assenza di consenso: la valutazione di testimonianze, circostanze, del comportamento dell’aggressore ma anche il silenzio, la passività o l'incapacità della vittima diventerebbero elementi rilevanti, non neutri. La difesa dell'accusato potrebbe ancora discutere la veridicità delle testimonianze, ma non potrebbe più basarsi sul fatto che "non c’è stata violenza" perché non sarebbe abbastanza per dimotrare che c'era il consenso.
Nei processi celebrati nei Paesi in cui esiste e viene nominato il consenso come elemento centrale nei casi di stupro, l’elemento chiave diventa la volontà della vittima: la mancanza di un “sì” esplicito o di un “no” chiaro diventa centrale per l’accusa e i tribunali valutano il contesto (messaggi, comportamento, incapacità di manifestare consenso). L’aggressore nei fatti può essere perseguito anche se non ha usato violenza fisica, basta che la vittima non abbia dato consenso libero, purché la testimonianza della vittima sia credibile e la sua esperienza "provabile" (come, non si sa).
Come si dimostra che il consenso non c'era (o che c'era)
Escludere la "violenza fisca" dall'equazione significa di certo un aumento dei casi perseguibili: abusi che prima non era possibile identificare come reati perché senza prova di coercizione ora possono essere considerati violenza sessuale. Ma rimane una immensa sfida probatoria quella che ci dice se il consenso c'era o no (a parte "sorella io ti credo"). Il consenso è mentale, quindi resta difficile da provare, non esistono test diretti, videocamere o "certificati di consenso" da sventolare in aula. La prova del consenso è quindi sempre indiretta, cioè si rimette a circostanze, testimonianze, messaggi, comportamenti. E qui casca l'asino: senza prove, il giudice deve basarsi su probabilità e coerenza narrativa. Il margine d’errore non è alto, è altissimo e la responsabilità della vittima è sproporzionata.
Partiamo da un dato: è chi accusa a dover dimostrare che non c’era consenso e nei tribunali dei Paesi democratici resiste (per fortuna) il principio di “oltre ogni ragionevole dubbio”. Senza violenza o minaccia, l’assenza di consenso si giudica su indizi inevitabilmente soggettivi, che possono essere perfino fragili o contraddittori.
Le testimonianze della vittima possono essere messe in dubbio, soprattutto se passano settimane o mesi (la storia ce lo insegna) e sulla base del comportamento (anche questo ce lo insegna la storia). Il comportamento post presunto abuso può essere di shock, di evitamento, di ansia ma non dimostra automaticamente mancanza di consenso.
Nel piano pratico, l'mpatto sul processo è quasi negativo: la durata e la complessità aumenterebbero in forza di più indizi da raccogliere, vittime da ascoltare, perizie da produrre. E gli esiti paradossalmente sarebbero meno prevedibili: la valutazione rimane - come è - soggettiva del/della giudice che però deve capire, con le sue esperienze anche personali e pregiudizi, se c'era il consenso oppure no senza prove di coercizione fisica. Ad aumentare è pure il rischio di impugnazioni: le decisioni basate su indizi indiretti possono portare a ricorsi da parte di chi si ritiene non colpevole.

 Volkswagen: crescono le vendite ma calano i ricavi
Volkswagen: crescono le vendite ma calano i ricavi