Un nuovo risultato del team internazionale STAR Collaboration ha acceso l’attenzione della comunità scientifica: nelle collisioni di ioni d’oro ad altissima energia sono state osservate fluttuazioni nei protoni che ricordano la turbolenza atmosferica. Per i fisici si tratta del segnale più convincente mai registrato di un possibile punto critico nucleare, una sorta di spartiacque nella mappa della materia.
L’idea di un punto critico in fisica nucleare nasce dal tentativo di descrivere come protoni e neutroni, composti da quark e gluoni, cambino fase in condizioni estreme. Così come l’acqua può presentarsi come solido, liquido o gas, anche la materia nucleare segue un diagramma delle fasi. A energie molto elevate, come quelle raggiunte al Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) di Brookhaven, i nuclei si fondono in un fluido primordiale chiamato plasma di quark e gluoni, lo stesso che permeava l’universo nei suoi primi istanti.
Il punto critico rappresenterebbe il confine tra diverse modalità di transizione di questa materia. Individuarlo equivale a piantare una “bandierina” fondamentale sulla mappa nucleare, con implicazioni che vanno dalla comprensione delle prime frazioni di secondo dopo il Big Bang ai processi nei nuclei delle stelle di neutroni.
Per riconoscere tale segnale, gli scienziati hanno analizzato le fluttuazioni nel numero di protoni prodotti. Questi sbalzi, paragonati a sacche di aria turbolenta incontrate da un aereo, possono rivelare una transizione nascosta. Per coglierne la traccia, i ricercatori hanno usato strumenti statistici di ordine elevato, in grado di descrivere le sottili variazioni della distribuzione dei protoni. Una misura chiave è la curtosi, che dovrebbe scendere, poi salire e infine stabilizzarsi secondo i modelli teorici.
Nei dati raccolti, la curtosi ha mostrato un minimo netto intorno ai 20 miliardi di elettronvolt per nucleone, con un ritorno al livello di base a 7,7 GeV. Questo andamento corrisponde a metà della firma predetta: un segnale parziale, ma significativo, con deviazioni comprese tra due e cinque sigma a seconda del riferimento usato. Sotto i 7,7 GeV, invece, le misure finora disponibili non hanno dato risultati conclusivi, lasciando un intervallo di energie ancora da esplorare.
L’esperimento, frutto di oltre 15 anni di lavoro, ha richiesto upgrades tecnologici dei rivelatori e delle infrastrutture di calcolo, dal centro dati di Berkeley al supercomputer del Brookhaven National Laboratory. È proprio grazie a questi strumenti che è stato possibile distinguere le delicate oscillazioni nascoste nelle collisioni di nuclei.
Secondo gli studiosi, compreso il teorico Mikhail Stephanov che aveva previsto l’andamento osservato, si tratta di un passo importante ma non definitivo: resta infatti da verificare l’altra metà della firma attesa. I dati aggiuntivi, già in raccolta a energie più basse, potrebbero presto colmare il vuoto e chiarire se il tanto atteso punto critico della materia nucleare è stato finalmente individuato.
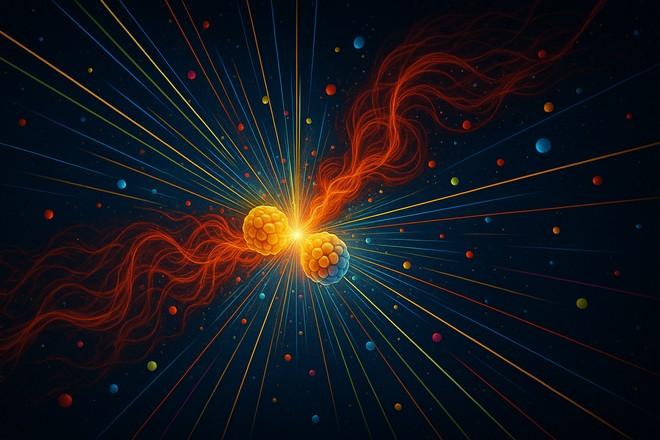
 Does the Dog Survive in Good Boy? We Have the Answer
Does the Dog Survive in Good Boy? We Have the Answer