Prevedere il tempo atmosferico per un intero mese e con una buona precisione molto presto non sarà più solo un sogno da meteorologi: grazie all’AI, oggi questa possibilità si sta facendo concreta. Fino a poco tempo fa, i modelli meteorologici convenzionali riuscivano a offrire previsioni affidabili solo entro una finestra temporale di circa 14 giorni. Oltre questo limite, le incertezze aumentavano in modo esponenziale, rendendo i risultati poco attendibili. Tuttavia, un recente studio guidato da Trent Vonich, dottorando all’Università di Washington, ha dimostrato che con l’aiuto dell’intelligenza artificiale è possibile superare questa barriera.
Il modello AI che ha compiuto questo passo avanti si chiama Graphcast, sviluppato dal team di DeepMind. L’obiettivo degli scienziati è stato quello di verificare se, partendo da condizioni iniziali molto accurate, si potesse estendere la portata delle previsioni meteorologiche fino a oltre 30 giorni. L’approccio adottato è stato ingegnoso: confrontare le simulazioni generate dal modello con dati di rianalisi – cioè archivi storici del tempo atmosferico già osservato – e adattare progressivamente le condizioni iniziali utilizzate per l’addestramento. Il risultato? Un miglioramento medio dell’86% nella precisione delle previsioni a dieci giorni e buone performance anche per periodi ben superiori.
Il punto interessante è che Graphcast, come altri modelli basati sull’intelligenza artificiale, non si affida alla soluzione delle complesse equazioni fisiche che governano l’atmosfera terrestre. Piuttosto, si basa su un approccio statistico e apprende dai dati osservati come evolvono le variabili meteorologiche nel tempo. Questo modus operandi consente un’enorme riduzione dei tempi di calcolo e un’efficienza computazionale molto maggiore rispetto ai metodi tradizionali, rendendo possibili simulazioni a risoluzione più elevata.
Grazie all’uso di architetture come i Transformer, questi modelli riescono a mantenere la coerenza interna tra le diverse variabili fisiche, evitando comportamenti "non realistici" che finora erano uno dei limiti principali dell’approccio AI.
Per comprendere l’importanza di questo cambiamento, basta ripensare alle origini della meteorologia moderna. All’inizio del Novecento, Lewis Fry Richardson aveva intuito che la fisica poteva essere usata per prevedere il tempo. Tuttavia, le sue prime previsioni, calcolate a mano, erano tutt’altro che precise. Solo con l’avvento dei computer e l’elaborazione numerica si è potuto costruire un sistema predittivo basato su equazioni fisiche complesse, ma questo approccio ha mostrato limiti chiari dovuti anche a variabili come il famoso effetto farfalla, teorizzato da Edward Lorenz.
Ora, con l’AI si apre una nuova fase, anche se non mancano le incognite: riusciranno questi modelli a mantenere la stessa affidabilità quando si trovano ad affrontare condizioni climatiche diverse da quelle presenti nei dati di addestramento? Le ricerche future dovranno dimostrarlo.
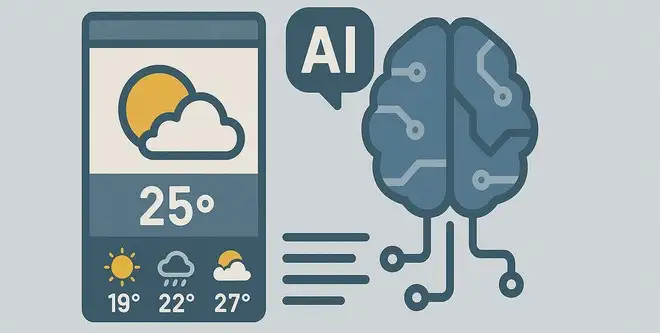
 Xiaomi Mix Flip arriva il mese prossimo con Snapdragon 8 Elite | Rumor
Xiaomi Mix Flip arriva il mese prossimo con Snapdragon 8 Elite | Rumor