Affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico richiede soluzioni innovative, ma a volte le risposte più efficaci possono arrivare da un passato lontano. Uno studio internazionale, che ha visto la partecipazione dell'Università di Milano, ha gettato nuova luce sulle antiche pratiche agricole, dimostrando come le comunità medievali abbiano saputo adattarsi a mutamenti ambientali con ingegno e resilienza. L'analisi si è concentrata sui terrazzamenti agricoli dell'Appennino settentrionale, in particolare nell'area di Vetto d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, svelando una storia affascinante di adattamento e gestione del territorio.
Grazie all'impiego di tecniche all'avanguardia, i ricercatori, guidati da Filippo Brandolini del Massachusetts Institute of Technology e dell'Università di Milano, sono riusciti a datare con precisione la costruzione di queste imponenti opere. Attraverso un metodo che analizza la luce emessa dai minerali di quarzo, hanno potuto determinare l'ultima volta che i sedimenti sono stati esposti alla luce solare. I risultati, pubblicati sulla prestigiosa rivista Scientific Reports, hanno rivelato che le prime fasi di costruzione dei terrazzamenti risalgono addirittura al IX secolo dopo Cristo.
Queste strutture non sono rimaste immutate nel tempo. La ricerca ha evidenziato come siano state continuamente modificate e adattate dalle popolazioni locali per rispondere alle sfide del tempo. Durante il "periodo caldo medievale", ad esempio, i terrazzamenti vennero ampliati e ristrutturati per sfruttare al meglio le nuove condizioni ambientali più favorevoli. Successivamente, con l'arrivo della "piccola età glaciale", caratterizzata da un calo delle temperature e da un aumento delle precipitazioni, si rese necessario un intenso lavoro di restauro dei muri a secco e dei terrapieni per preservarne la stabilità e la funzionalità.
"Le terrazze di Vetto, oggi in parte abbandonate, sono molto più che semplici tracce del passato. Rappresentano esempi concreti di come le comunità locali abbiano saputo modellare il territorio per affrontare sfide ambientali, economiche e demografiche".
In un'epoca come la nostra, in cui l'erosione del suolo e la necessità di un'agricoltura più sostenibile sono temi centrali, la riscoperta di queste tecniche antiche potrebbe assumere un'importanza strategica, aggiunge Brandolini.
"In un contesto come quello attuale, in cui il cambiamento climatico impone nuove strategie di gestione del territorio, riscoprire e valorizzare questi sistemi potrebbe offrire soluzioni efficaci per rafforzare la resilienza delle aree montane".
L'agricoltura di montagna, in particolare, potrebbe trarre grande beneficio da questa saggezza antica, trasformando un'eredità storica in una risorsa preziosa per il futuro.

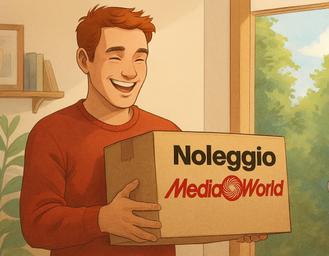 I dispositivi non si comprano più, si noleggiano da Mediaworld. È un sistema che può funzionare per i privati?
I dispositivi non si comprano più, si noleggiano da Mediaworld. È un sistema che può funzionare per i privati?